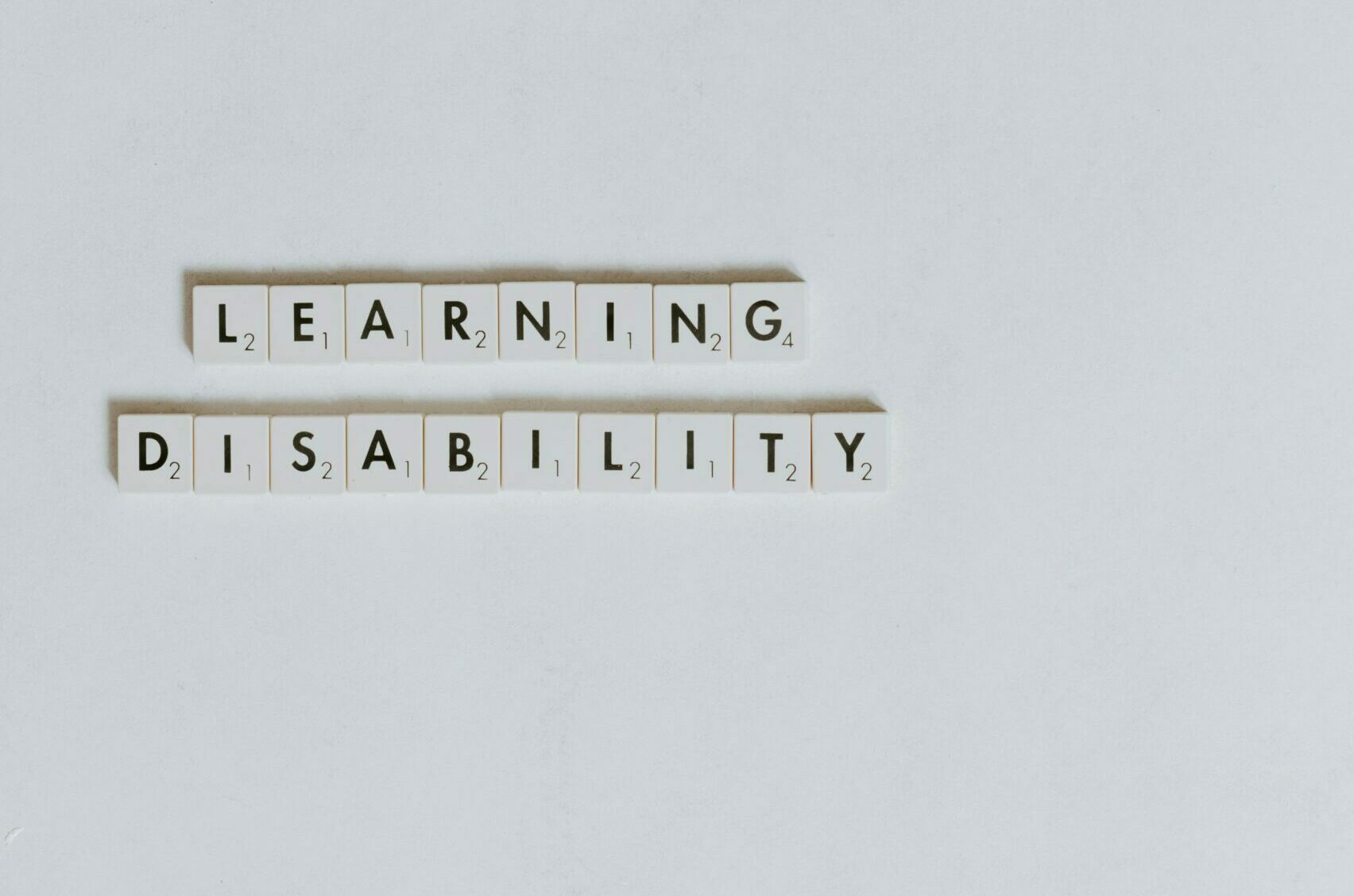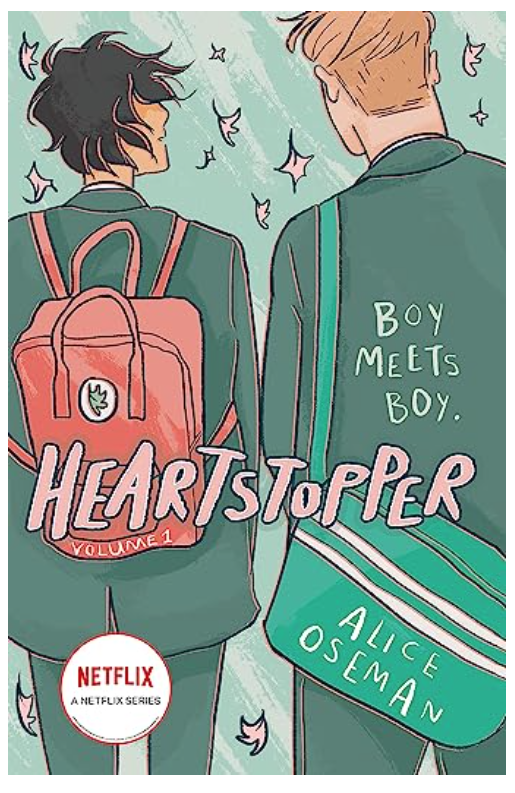In Italia le persone con una disabilità sono 13 milioni. Parliamo tanto di inclusività, ma quanto siamo davvero inclusivi anche all’interno della nostra comunità? Quanto sono “aperti” oggi i luoghi di incontro LGBTQIA+ a chi ha una disabilità? Chi frequenta le associazioni LGBTQIA+ sa che per anni hanno dovuto accontentarsi di punti di ritrovo di fortuna. Quando si decide di essere visibili, i luoghi della “visibilità” non sono così facilmente accessibili. Quanto è importante, nel 2023, iniziare a parlare di corpi invisibili e di disabilità? Forse lo è più che mai. E noi iniziamo da qui.
È stato curioso, all’improvviso, rimpiangere di essere invisibile.
Per un ragazzo come me con disabilità, che si sposta su una sedia a rotelle motorizzata da 100 chili, l’invisibilità per lungo tempo non sarebbe sembrata una minaccia, ma un dono. Abituato a essere oggetto di osservazione e analisi a qualunque festa, in qualunque classe scolastica o in qualunque negozio mi recassi, facevo del mio meglio per apparire meno “disabile”. Sceglievo sempre gli ausili meno vistosi, ai primi appuntamenti tenevo la schiena fermamente appoggiata allo schienale per non far vedere le storture, indossavo pantaloni sotto la caviglia anche in estate (per non far vedere i piedi “stortarelli”) e mi imponevo di gesticolare il meno possibile, perché i miei movimenti non erano sempre fermi. Piccole illusioni con cui probabilmente mi ingannavo solo io e con le quali però mi stavo adeguando a quello che questo Paese, l’Italia, sembra aver chiesto alle persone con disabilità per intere generazioni: nascondetevi, rimanete in casa con le vostre famiglie, non date fastidio. E io, nella mia ingenuità, ero il primo soldato sulla frontiera di questa secolare opera di insabbiamento.
Poi, per fortuna, è arrivata l’adolescenza, la voglia di essere me stesso e magari di fare politica, affermare la mia identità, trovare persone come me, fidanzarmi, fare sesso. Certo, forse l’ordine esatto delle priorità non era esattamente questo, ma già solo desiderare tutte queste cose, in un Paese che quando parla di disabilità e affettività si nasconde dietro un angolo, era come scoperchiare un vaso di Pandora. Un giorno, nella mia camera da letto, decisi di provare a mettermi in gioco, conoscere persone, vedere dove sarei potuto arrivare nella realizzazione di desideri che prima non osavo nemmeno immaginare. Uno sforzo immane che in pochi sanno affrontare da soli, ancor meno ci riescono, e per il quale volersi sentire parte della grande famiglia LGBTQIA+ può essere naturale, e spesso anche un supporto che salva la vita.
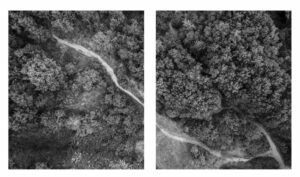
Ma quanto sono “aperti” oggi i luoghi di incontro LGBTQIA+ a chi ha una disabilità?
Non ci sono dati concreti, una vera mappa non è mai stata fatta. A Londra nel 2017 Buzzfeed fece un meraviglioso reportage che dimostra, di fatto, che in centro città non esistono luoghi di incontro LGBTQ+ accessibili a chi è in sedia a rotelle. Sul tema era emersa anche una interrogazione al sindaco, con risposte decisamente evasive. Ecco, se questo è lo stato delle cose nella City, figuratevi in Italia: nelle grandi città e in periferia. Chi frequenta le associazioni LGBTQIA+ sa che per anni hanno dovuto accontentarsi di punti di ritrovo di fortuna: sgabuzzini, sotterranei, spazi angusti ceduti quasi per distrazione da qualche amministrazione comunale. Nel comune in cui vivevo, prima di trasferirmi a Milano, gli spazi non erano accessibili e anche i locali “friendly” stavano di fatto in qualche sotterraneo di periferia. A questo aggiungiamoci le città già non accessibili di per sé, trasporti pubblici inesistenti e le enormi difficoltà dell’avere una patente quando sei in sedia a rotelle. Insomma: quando volevo essere visibile, conoscere, muovermi, mi accorsi di non poterlo essere, semplicemente perché i luoghi della “visibilità” non erano per me accessibili.
Non lo erano per me, così come probabilmente non lo erano e non lo sono per le tante persone con una disabilità: 13 milioni di persone lungo la Penisola.
Come se ne esce e, soprattutto, come si conoscono altre persone? Una risposta, per iniziare, oggi, sono le app. Lì però l’invisibilità che ti contraddistingue è quella del tuo corpo. La tua immagine, tra addominali e foto in spiaggia, si troverà bene come quel dinosauro che da bambino nascondevi nel presepe di nonna. La diversità di chi ha corpi (appunto) diversi, è un’altra invisibilità: magari non metti la foto, e quando te la chiedono ti ritrovi ad “avvisarli” prima di cosa vedranno, di scusarti per quello che sei, come se fosse una colpa.
Ci sono poi le discoteche e i luoghi della movida: solo a Milano sono poche quelle davvero accessibili (e non ci spingeremo fino alle dark room, non temete).
Al primo appuntamento, in una celebre via della movida milanese, mi ricordo di essere arrivato in anticipo per farmi “sollevare” dal proprietario di un locale, senza farmi vedere da nessuno. Quando poi magari, nonostante tutto e nonostante tutti, inizi a divertirti, magari vuoi informarti, fare le cose per bene… scoprirai che il citofono del centro informazioni per le MST, sempre a Milano, è troppo alto per chi è in sedia a rotelle. Credo ricorderò per tutta la vita la faccia del passante a cui chiesi di citofonare per me:
“Ma devo suonare il citofono del centro malattie trasmissibili?”
“No guardi, non è per me: è per un amico!”
A inventare scuse, evidentemente, non sono mai stato bravo, la mia lotta però ho voluto farla: perché se io non ho trovato aiuto, qualcuno in futuro dovrà pur trovarlo. Alla veneranda età di trent’anni, qualche anno fa, decisi che era troppo: dovevo condividere parte della mia storia. Così iniziai a fare due cose: limonare sugli autobus (specialmente se c’erano vecchie “sciure” milanesi intente a scrutarmi) e, più concretamente, andare ai Pride. Manifestazioni che nascono come marcia, sotto il sole e sopra i carri: a meno di trasformare le sedie a rotelle in carri (cosa che prima o poi faremo), è evidente quanto non sia il tipo di manifestazione più facile da rendere inclusiva. Su questo fronte però l’impegno c’è e, sempre per fare un esempio, a Milano nel 2023 lo sforzo è stato a dir poco straordinario. I pride sono all’aperto, ci sono una volta l’anno, e magari sistemare una manifestazione è più facile di sistemare un problema di strutture architettoniche e sovrastrutture mentali.
Ma è lì per me che è accaduta la magia, quando il visibile è diventato allo stesso tempo invisibile: per la prima volta, al mio primo pride, non ero preoccupato degli sguardi altrui, e nel fiorire delle diversità fatte di corpi, strass, slogan e pailettes la mia diversità risplendeva e si annullava, in una sola luce arcobaleno. Ero finalmente un raggio tra i tanti.
Quanto è importante, nel 2023, iniziare a parlare di corpi invisibili e di disabilità? Forse lo è più che mai. Oggi viviamo in un Paese dove della disabilità dovrebbe occuparsi il Ministero della disabilità, nato nel 2018 come ministero “Famiglia e disabilità”. Quella “e” tra “Famiglia e disabilità” mi ha sempre messo curiosità: è perché i disabili non possono essere una famiglia, o perché i disabili dovrebbero vivere solo chiusi in famiglia? Da cosa deriva questa associazione? Probabilmente l’accostamento è quello semantico del “tradizionale, buono e buonista”. Oggi ministeri di famiglia e disabilità sono separati, eppure gli effetti collaterali sono sempre gli stessi: farsi una famiglia sembra impossibile sia per le coppie LGBTQ+ sia, quasi sempre, per coppie “tradizionali” in cui uno dei due componenti ha una disabilità. Almeno in questo, nella discriminazione, siamo sempre accomunati. Un Paese così, l’intersezionalità tra famiglia arcobaleno e disabilità probabilmente riuscirà a vederla solo tra qualche secolo.
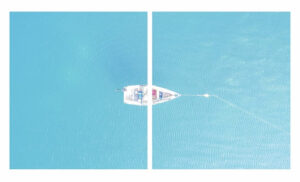
Il vero problema, però, è che l’inclusione non dovrebbe partire da un ministero autonomo (come hanno detto persone più competenti di me) ma essere inclusa a tutti i livelli, a partire dalla demolizione di un’immagine stereotipata della disabilità: un’immagine vista come asessuata o, se “sessuata”, decisamente poco fluida. Il dibattito sulla sessualità dei disabili sembra essersi inchiodato da anni sul tema dell’assistenza sessuale, incapace di immaginare anche altre forme di affettività, magari diverse, magari a più ampio spettro. Spesso ad occuparsi di disabilità, negli istituti medici o nelle scuole, sono ancora istituzioni legate o sovvenzionate dalla Chiesa Cattolica: certamente un lavoro encomiabile, ma che porta con sé anche un’impostazione culturale che potrebbe non rappresentare chiunque.
A partire dagli anni ‘80 chi si occupa di disabilità non descrive la persona con disabilità come paziente, ma si focalizza su un modello sociale: il “problema” nella disabilità non è da ricercare solo nella persona, ma anche e soprattutto in un contesto non in grado di accoglierla e vederla. In Italia, invece, il concetto di disabile come paziente è ancora forte, e schiaccia queste persone contro degli stereotipi buonisti o “eroici” in cui è impossibile immedesimarsi.
Quindi sì, se da una parte la comunità LGBTQIA+ si sta conquistando un mare di visibilità e rappresentazione, c’è chi vive ancora nell’ombra. Le persone con disabilità possono fare la loro parte, smettendo di essere invisibili e pretendendo maggior riconoscimento: ma per farlo, chi sta dall’altra parte, deve aprirsi all’accessibilità e alla capacità di guardare con occhi nuovi.
[Foto di Marzio Bongarzone – IG: @marziobongarzone]