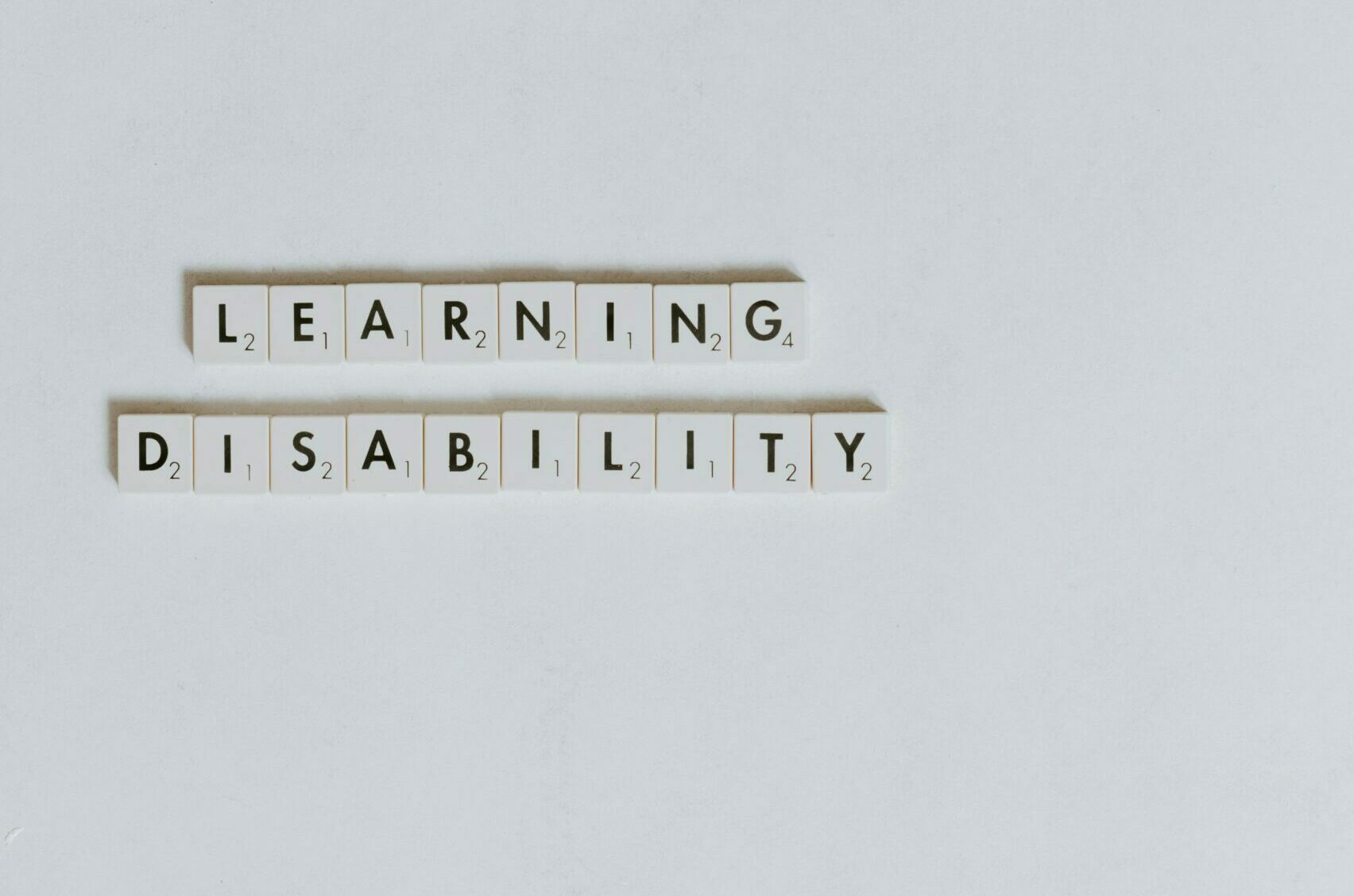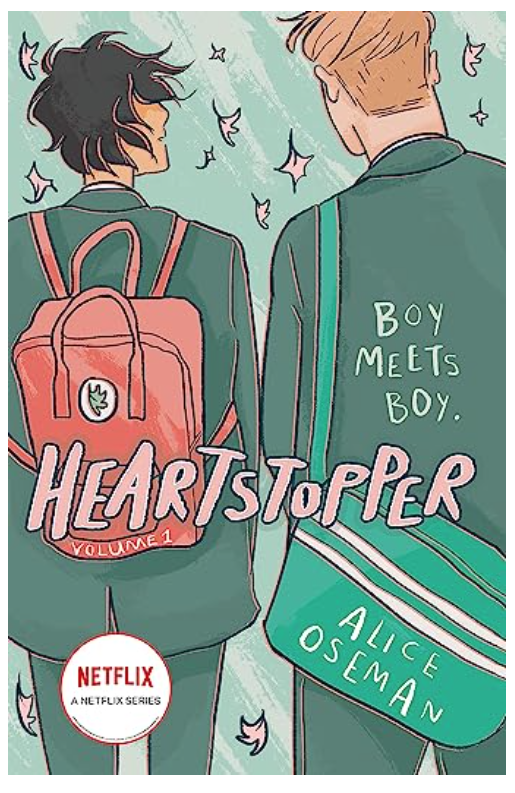In antropologia c’è un modo per indicare come le generazioni più grandi guardano quelle più piccole: “from top to bottom”. Significa “dall’alto al basso” e indica quello sguardo distaccato che si pone al di sopra delle parti e che ci impedisce quindi di poter creare un’analisi che sia quanto più oggettiva possibile. E’ un detto che troviamo declinato in mille contesti diversi, dobbiamo ammetterlo, ma quando lo inseriamo all’interno delle scienze umane ricorda, a chiunque stia effettuando una ricerca, uno degli errori in cui è più facile cadere. Non è un caso infatti che in antropologia si presti così tanta attenzione alle varie fasce generazionali dei vari attori e attrici che si vanno ad intervistare, perché le loro risposte potrebbero cambiare in base al tipo di educazione che hanno ricevuto che potrebbe essere differente da quella di altri individui in base agli anni in cui hanno vissuto la loro vita.
Insomma, non solo è impossibile riuscire ad avere uno sguardo e un approccio completamente oggettivo rispetto alle persone che andremo ad intervistare, ma in più l’aspetto generazionale complica non poco le cose. Tanto è vero che fare antropologia con bambini e bambine molto piccoli è difficile quanto approcciarsi ad una civiltà mai scoperta, perché solitamente hanno codici e linguaggi unici che sono molto difficili da poter riportare scientificamente.
Questa incomunicabilità la riscontriamo anche nel modo in cui i media tradizionali, come giornali e televisione, spesso raccontano le nuove generazioni. Con l’arrivo dell’attivismo social, le voci si sono moltiplicate facendo luce, per esempio, su moltissime forme di discriminazione sempre presenti, ma che oggi finalmente vengono denunciate. Questo nuovo approccio nel raccontare la realtà è spesso profondamente in contrasto con i vecchi media che ripropongono proprio quello sguardo distaccato dall’alto al basso da cui l’antropologia ci mette in guardia.
Estremamente eloquente il caso di qualche mese fa di un noto programma televisivo, in cui si decise che i responsabili della violenza di genere oggi sono principalmente i giovani. Nel programma, diverse figure, apparentemente, molto qualificate, con decine di anni di esperienza all’attivo, si riferivano ai più giovani, i late Millennial e la generazione Z, come la “generazione snowflake” (fiocco di neve): giovani che difendono così tanto la loro unicità e la loro fragilità, a tal punto da non sapere più gestire la complessità della realtà in cui vivono. I ragazzi, raccontava il sociologo in collegamento, non sarebbero più abituati a ricevere un rifiuto in una relazione e questa delusione, a causa della loro fragilità e alla loro esigenza di volersi sempre proteggere da tutto, sarebbe così insostenibile da fargli compiere persino atti efferati. Peccato che oggi l’età media delle persone coinvolte in un femminicidio si aggiri attorno ai 50 anni, quindi stiamo parlando dei cosiddetti Baby Boomer, ben lontani quindi dalle nuove generazioni.
Questo fenomeno però non è solo un problema di incomunicabilità generazionale. Quando parliamo di discriminazioni, e di come quelle discriminazioni vengono raccontate, non possiamo non riconoscere il ruolo che il potere ha in questa dinamica.
Viviamo in una società che ha imposto delle gerarchie molto chiare sui corpi e sulle identità delle persone e questo sistema di potere farà di tutto per preservarsi e farà di tutto per manipolare ogni forma di protesta che potrebbe metterlo in difficoltà.
Esattamente come nell’universo distopico presentato nella seconda puntata della prima stagione di “Black Mirror” intitolata “15 millions merits”: il protagonista, Bing Madsen, alla fine dell’episodio cerca di denunciare il sistema minacciando di uccidersi su un palco di un reality show. Verrà però premiato dallo stesso sistema per il suo gesto e gli verrà assegnato un intero programma in cui continuare a raccontare il “marcio della società” e una vita di lusso. In questo modo, il sistema disinnesca completamente il gesto rivoluzionario di Bing e riprende il controllo della situazione.
Non è un caso infatti che a persone che si occupano di attivismo o divulgazione venga spesso chiesto loro di “portare il loro trauma” (frase che metto virgolettata perché l’ho sentita più volte e in ogni tipo di contesto, più o meno consapevole). Basta mostrare le nostre ferite, fare una spettacolarizzazione del dolore, creare ancora una volta un agnello sacrificale che ci permetta di espiare i nostri peccati, o nel peggiore dei casi, che ci aiuti a decidere se quella identità sia meritevole della nostra grazia o debba effettivamente essere discriminata.
Si creano panel e salotti televisivi in cui si sottolinea l’importanza di un contraddittorio in cui però i rapporti sono completamente sbilanciati: da un lato abbiamo chi è chiamato a difendere la propria identità e la propria esistenza e dall’altra ci sono delle persone che semplicemente non sono d’accordo. Ma come possiamo pretendere che una persona trans possa raccontare la sua storia davanti a figure politiche o associative, preparatissime a quel tipo di contesto, che descrivono il tutto come “un contagio sociale”?
In questo modo, così come nell’episodio di Black Mirror, proponiamo una narrazione che ci allena a dispiacerci per la discriminazione altrui, che riconosciamo come brutta e cattiva, ma è sempre uno sguardo distaccato e, in fondo in fondo, disinteressato. Non c’è quindi l’interesse di raccontare perché nasce una discriminazione, di capire realmente il disagio della persona a cui stiamo chiedendo il suo trauma, di tutelare la persona che deve mettersi in una condizione di vulnerabilità per portare una parte importante della sua storia. Nulla. Ciò che conta è la notizia e preservare il proprio potere.
Le storie e le testimonianze degli individui sono preziosissime e meritano di essere raccontate, ma mai strumentalizzate. Ecco perché le scienze umane sono così importanti accanto alle storie: permettono di essere lette anche tra generazioni differenti e le tutelano anche da tutti quei poteri che tentano costantemente di assoggettarle.